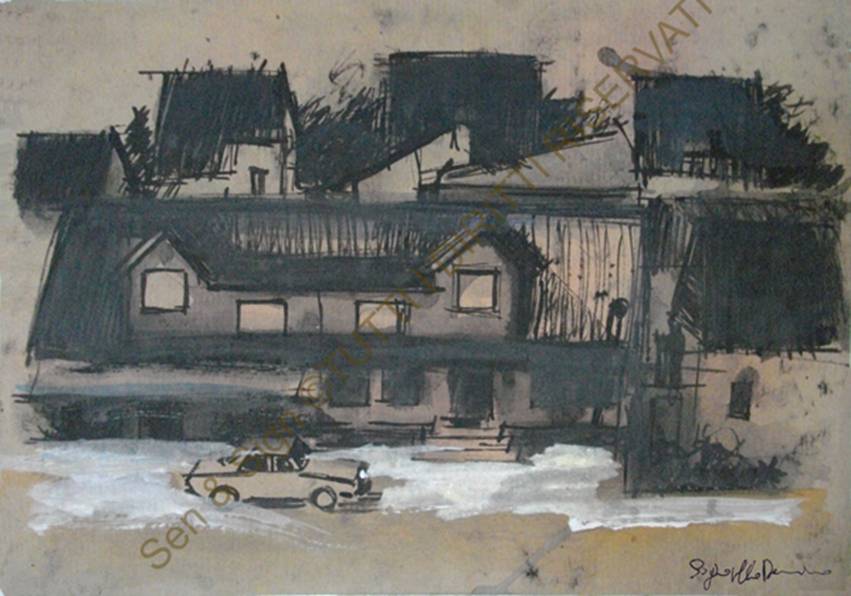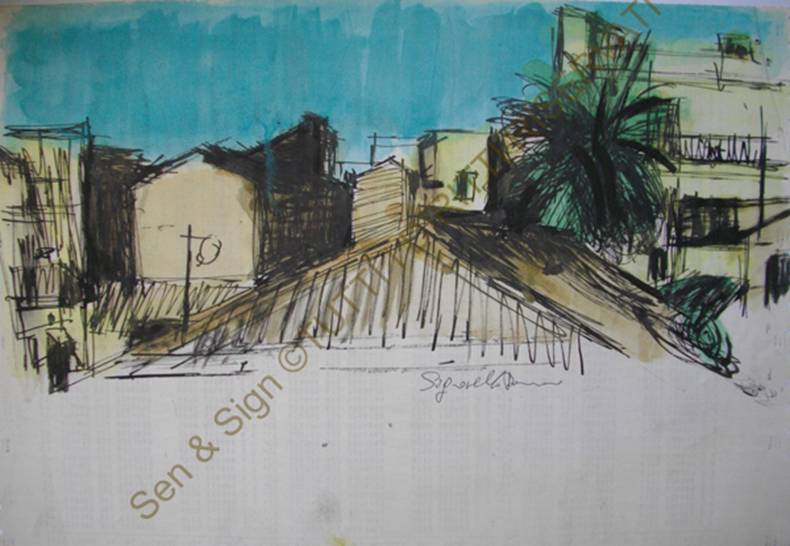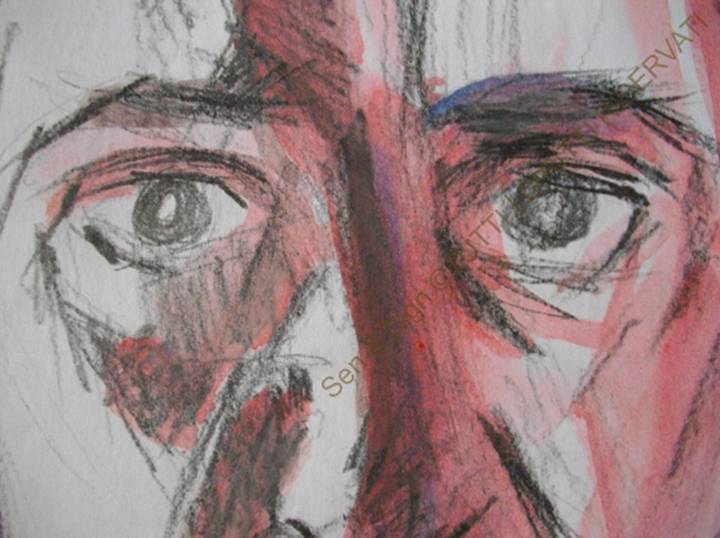|
Domenico Signorello – Biografia |
|
|
LA VITA IN UN AUTORITRATTO
|
|
|
L'artista Domenico
Signorello nasce nel Con non pochi
sacrifici, la madre capite le strabilianti capacità del suo primogenito, si
trasferisce con i suoi altri tre figli a Catania per fare intraprendere a
Domenico l'allora scuola superiore "Istituto statale d'arte", dove
fu ammesso grazie alle sue alte
capacità artistiche, nonostante non avesse conseguito la licenza di terza
media. L'artista,
trasferitosi in città dalla campagna, incontra parecchie difficoltà
sopratutto nell'ambiente - "artistico/scolastico" catanese - degli
anni sessanta, composto da artisti per lo più pieni di se e da alunni
appartenenti a stati sociali medio - alti. Così, se da un
lato l'allora giovane e "forte" artista Domenico Signorello viene
ampiamente motivato per le sue straordinarie doti artistiche a inserirsi nel
nuovo ambiente, contemporaneamente si trova catapultato in “situazioni” più
grandi di lui senza nessuna guida e protezione - infatti entrerà a far parte
della cerchia di quei giovani che poi diverranno odierni maestri come: Giuseppe Leanza, Antonio Santacroce,
Luciano Schifano, Silvio Signorelli, Pippo Di Giunta, e il
conosciutissimo attore Leo Gullotta:
tutti frequentanti la stessa classe insieme all’artista Domenico Signorello. Potremmo citare
anche altri, allora giovani studenti dell’Istituto Statale d’Arte di Catania,
presenti in quegli anni (1960/1962), come per esempio, l’odierno pittore e
scultore Salvatore Tropea, - e altri
ancora, odierni maestri catanesi -, tutti formatisi quindi in un clima di
pieno fervore artistico grazie ai grandi nomi degli allora insegnanti/maestri
d’arte componenti la
cosiddetta “Scuola di Catania” come: Nunzio Sciavarrello
(1918), Francesco Ranno
(1907-1986), Carmelo Comes
(1905-1988), Pippo Giuffrida
(1912-1977). Uno dei tanti
aneddoti raccontati, vede l’artista Domenico
Signorello durante gli anni (1960-1962),
partecipare a una mostra insieme ai compagni di classe Luciano Schifano e Giuseppe
Leanza, con un suo quadro che viene recensito con un articolo sul
quotidiano “ La Sicilia” dal noto
giornalista Indro Montanelli. Lo
stesso quadro è poi acquistato dal noto giudice
Paglialunga di Lentini. Quando l’allora preside dell’Istituto d’Arte, lo
scultore catanese M. M. Lazzaro ne
venne a conoscenza ci tenne a voler vedere, personalmente, l’opera del suo
studente che aveva riscosso così tanto successo. Pertanto,
nonostante le condizioni favorevoli, e i riconoscimenti artistici riscossi,
contemporaneamente, il giovane Domenico è sottoposto a parecchie angherie e
gelosie suscitate dalla sua arte e dagli incoraggiamenti che stava ricevendo.
In questo
vortice di contraddizioni sociali/culturali e familiari, l’artista Domenico a
un anno dal diploma (allora di soli tre anni) abbandona gli studi, facendo la
valigia ed emigrando all'estero all' insaputa dei familiari. Da qui inizia
per l'artista un susseguirsi di vicende in continua contraddizione. Passa da una
città all'altra, del Nord - Italia; vive tra Francia, Olanda e Germania
e in diverse città dell'Europa. Per sopravvivere farà l’operaio prima alla
Fiat di Torino e in seguito alla Wolswaghen in Germania. In concomitanza
fa diverse mostre e annovera targhe e "targhette" (riconoscimenti
che ben presto egli schiverà fuggendo il facile fascino delle mode e gli
allettanti richiami alla notorietà). Continua sempre
a disegnare dal vero tutto ciò che vede, ma sopratutto quei luoghi così
diversi dal suo paese di origine: famose le vedute dei
tetti e delle strade imbiancate e “fredde” della Germania, come anche le
campagne dell'Olanda, dove si ravvisano nella preziosità dell’accurata
trama segnica, e nella sapienza del dosaggio dei neri e dei grigi una corrispondenza
con certe incisioni fiamminghe e olandesi (Rembrandt). Numerose anche le
vedute urbane dei caseggiati bianchi della cittadina Wolfsburg, dove
riecheggiano nel segno largo e nei colori puri le tele espressioniste di
Kirchkner. Di questa cittadina della Germania ne ha disegnato anche il
castello, facendolo riemergere tra colori nebbiosi di noldiana memoria. Tantissimi sono
ancora i disegni di Domenico Signorello delle vie caratteristiche di Catania con
vedute dall’alto e riprese di tetti, vie e palazzi vetusti, dipingendoli col
nero rovente dei loro muri di pietra lavica di cui sono fatti, in contrasto
con i cieli e le palme, inondati dalla luce tersa della Sicilia. Sicilia, che
ritorna nei disegni della sua amata Belpasso,
delineata con segni sicuri e decisi alla ricerca di prospettive e profondità
del paese etneo. E tra le sue campagne
e sciare ha scoperto il fascino agreste di una casetta
diroccata, al punto di riproporla in una serie di piccoli e preziosi
dipinti. Come anche le solitarie nature
morte con oggetti di uso quotidiano e vasi con fiori. Infine la sua
principale e primordiale ricerca mai abbandonata, l'autoritratto, motivata dallo
stesso artista, quando gli si chiede come mai la sua miriade di autoritratti,
egli risponde: "In
assenza di modelli, disegno me stesso". Denotando forse
in questo modo, la solitudine inconscia originata dalle contraddizioni della
sua stessa vita - sempre più isolato dai movimenti di gruppo e dalle
consorterie della pittura ufficiale - segue una ricerca appassionata e
profonda della propria personalità -. L'artista si
sposa a Catania nel 1972 e
all'indomani si trova già a Torino, dove nel 1973 nasce la sua primogenita
(Stefania), poi si sposta quasi immediatamente in Germania, dove
nel 1978 nasce la seconda figlia. Ma nel 1982 è a
Catania, dove si separa dalla moglie subendone un duro contraccolpo. Negli anni ottanta
trascorre la sua vita tra Catania e la Germania, fino ai primi anni novanta, quando si "ritira"
definitivamente nella casa natale alle pendici dell'Etna, vivendo di stenti per dedicarsi
esclusivamente alla sua arte, escludendo le distrazioni e le preoccupazioni
legate al vivere comune del quotidiano - proprio per conseguire la famigerata
“tranquillità” negatagli - portando così alle estreme conseguenze i suoi
autoritratti. Lo stesso
artista dice: "vedo nei miei ultimi autoritratti
qualcosa che sparisce, confrontandoli con quelli che disegnavo un tempo - in
questi ultimi - è come se lo sguardo comunichi il nulla, oppure l'incerto
futuro, come profetica avvisaglia che niente di buono possa più accadere". Rivelandosi,
anche per quest'ultimo motivo, artista del contemporaneo. Nei suoi
dipinti si evidenzia l'espressione che cambia, da forte a indecisa,
privilegiando sempre lo sguardo che comunica. L'espressione del volto, è univocamente unita al
luogo, al tempo, alla luce e quindi alla vita stessa, ne identifica il
trascorrere, il cambiamento, e per ultimo, l'incertezza - quella trovata dall'artista nella recente
produzione - come raffigurazione di
uno sconcerto sfuggente -, perché questo tempo presente cambia troppo
velocemente. Questi quadri,
così, si datano e si firmano da se stessi: l'autore è il quadro stesso, fatto
dal suo tempo. Il tempo è lo sguardo dell'artista, la vita stessa: "L’attimo vivo" di cui egli
"parla". L'artista
afferma di sentire la massa e di fare risaltare la forza del volume,
privilegiando, nell’autoritratto, lo sguardo che deve "parlare";
quindi, tanti tenaci autoritratti che hanno diverse espressioni e che devono
trasmettere “qualcosa”: denominato dallo stesso artista, "lo sguardo vivo" - perché legato all’attimo presente e
irripetibile, della luce e dello stato d’animo dell’artista -. Nei suoi recenti
autoritratti lo sguardo sembra "che
guardi qualcosa che lo spaventa": "il quadro deve cogliere l'attimo vivo, perché deve colpire, non
lasciare indifferenti". Infatti, l’artista lega la riuscita
dell’opera alla resa dello “sguardo
vivo” che dura pochi attimi nel divenire del tempo e dell’essere.
Cosicché, mutamenti, della stessa visione retinica come anche interiore
(perché cambia il tempo e l’artista stesso) sono impressi dall’ artista
nell’attimo prima che essi siano cambiati. Ne risulta un continuo (forse
inconscio) trasformare l’opera stessa - che non è mai quindi finita - in un
susseguire di aggiungere e togliere. Ciò determina spesso la scontentezza
dello stesso artista in un voler inseguire una sua ideale perfezione, e il
suo non sentirsi “pronto” - all’altezza del “tempo” -. Spinto, quindi, a dei
continui reinizi per un’intera vita. Sviluppando in
questo modo innovazioni nell'operare artistico, con personali
tecniche e stile, per l'uso del colore, della luce, ma sopratutto,
riconoscendo Domenico Signorello per il forte intreccio tra arte e vita che
incarna nei suoi lavori. Parlando con
l’artista egli spesso dichiara frasi del tipo…. “ non sono ancora riuscito
nel mio intento”… oppure …” non mi sento ancora pronto”… Evidenziando
l’illimitata e continua ricerca tipica dell’Arte vera! Oggi la figlia,
Stefania Signorello (scultrice, insegnante e poetessa) ritiene che il padre
faccia parte dei grandi artisti
contemporanei, "non ancora scoperti " come
tanti altri artisti, annoverati appunto "artisti senza
voce", molti dei quali apparteranno alla vera storia dell'arte di domani.
Per l’artista Stefania Signorello, l’operato del padre è di inestimabile
valore ancor più perché personale e privato: collegato al proprio mondo e
alla personale vita. In Domenico Signorello riconosciamo l’arte vissuta
appieno come vitale esistenza inscindibile: l’arte come modo di essere se
stessi – quello che si è realmente -, l’artista che lotta per rimanere tale
nonostante la realtà contemporanea. IL PERSONAGGIO: L’ARTE COME TERAPIA Artista dal
carattere rigoroso, vivace e sveglio; amante della giustizia, ricercatore
della verità, schivo ai compromessi, seguace di antiche saggezze e filosofie
di vita; da sempre, attento ai particolari e al ragionamento logico, ma al
tempo stesso sostenitore della gioia di vivere, dell’allegria e della
maestosità. Artista sicuramente non semplice perché legato infinitamente al
concetto di “puro”. Tale natura gli ha procurato non pochi problemi fino al
punto da travisarne lo spirito: spesso l’artista è stato scambiato per uomo
caparbio e dal carattere duro, tanto da far sentire qualcuno autorizzato a
pregiudicare i diritti stessi dell’artista. Infatti, in tanti momenti della
propria vita egli anziché cadere vittima, contrariamente - da battagliero -
ha protratto la spada mantenendo intatto il suo essere, rispecchiando così la
sua innata personalità e il suo carattere. Reduce di rapporti difficili dati da
incomprensioni reciproche e dalla sua inclinazione a non dover perdere solo
per il piacere di altri. Spinto
all’isolamento da diverse vicende familiari ed esterne, l’artista non ha mai
smesso di ricercare la famigerata “tranquillità” e “l’armonia” rispecchiando
nell’arte l’amore per l’intelligenza e la coerenza del suo vivere. Pian piano
portato a vivere di stenti si è dedicato esclusivamente alla sua arte
trovando in essa un riscontro di benessere e piacere. Ricercatore
appassionato della verità, attento alla realtà, osservatore del reale,
l’artista da sempre, in un crescente bisogno, trova una personale
soddisfazione nel registrare graficamente tutto
ciò che lo circonda, attribuendo all’operare artistico la magia di far
dimenticare tutti i problemi, per dedicarsi completamente ai problemi del
visivo senza limiti di tempo. L’artista dichiara di aver sempre visto l’arte
come un operare personale e non come un mezzo per diventare ricchi o famosi. Spesso, durante
il corso della propria vita, l’artista ha dovuto lottare con chi puntualmente
cercava di estorcergli le proprie cose, negandogli i propri diritti e allo
stesso tempo anche il successo, costringendolo così per la sua quasi intera
vita a una preziosa perdita di tempo, spreco di talento e ad avere rapporti
tesi - fondati non più sulla normale fiducia-. Queste relazioni esistenziali,
l’hanno portato ad avere una visione dei rapporti umani disincantata e a
volte amaramente cinica: tutto ciò per necessità non certamente per natura.
In questa situazione le sue costanti ancore di salvezza sono state la pittura e il disegno, che hanno contribuito a
riaffermarlo, consentendogli comunque di conservare la sua identità che gli è
stata spesso negata nei rapporti interpersonali. Quest’affermazione
di sé si è rivelata soprattutto nel corso degli anni nella costante forma
artistica dell’autoritratto. Esplorato nelle varie
declinazioni pittorico/ disegnative, che vanno dal chiaroscuro più classico
del “periodo nero” fino all’uso più
libero e sperimentale del colore e della
forma. In cui troviamo anche accensioni Fauve e quasi espressioniste in
alcuni autoritratti dove il colore fa da
padrone, nella sempre solida costruzione dei volumi. Mentre in altri
autoritratti l’artista ricerca un’armonizzazione tra il segno della grafite e le pennellate della
tempera. Ritroviamo anche in altre versioni dell’autoritratto la ricerca di
una sintesi grafica, estrema, dove il segno
predomina. Tutto ciò nell’arco di un’intera vita dedicata all’autoritratto:
una costante e fedele ripresa di se stesso allo specchio, nel passare del
tempo, della forma e delle sperimentazioni coloristiche – come a voler dire –
“tutto cambia, tutto passa e finisce, ma l’arte rimane “-. La sua ricerca
stilistica mira al superamento del realismo fotografico e che decisivamente
lo scarta (poiché l’artista stesso dichiara “sono
figurativo, ma non fotografico”) a favore di un altro tipo di
realismo che si realizza nell’espressività del tratto, nella resa volumetrica
ottenuta tramite l’uso sapiente del chiaroscuro e la ricerca dell’equilibrio
cromatico, rivolti alla resa “viva” dell’espressione visiva e psicologica del
soggetto ritratto ( qualunque esso sia, in particolare l’autoritratto). L’artista mira
soprattutto a registrare graficamente tutto ciò che lo circonda, utilizzando
il suo personalissimo ed esclusivo stile nel perseguire la sua visione dal
vero. Egli sostiene: “Io cerco in assoluto… cioè vorrei in
primissima esigenza/sequenza riportare ciò che vedo sul foglio, e per tale
motivo - per tale ragione - “lotto”
nell’intento della resa tridimensionale che deve essere più reale possibile a quello che vedo, che ho davanti ai miei occhi. Ma spesso, anzi
quasi sempre, non ne sono per niente contento!, succede così che ripeto
all’infinito l’operazione, anche lo stesso lavoro, viene ripetutamente
incessantemente ripreso nel tempo”.
A volte, per esempio, i tratti appaiono all’artista troppo scuri perché
appunto vi ha ricercato la verità, intesa anche come resa tridimensionale e
spaziale di un insieme che deve risultare con un suo ben preciso equilibrio
(“non deve stonare”), allora,
l’artista letteralmente “lava” con acqua - e a volte con sapone - il suo
lavoro, così da risultare più sbiadito, ma poi, quasi sempre, vi reinizierà -
tornandovi sopra - lo stesso procedimento di “ricerca” , nell’intento di
riscattarne e ricercarne la “fuoriuscita” grafica del soggetto, nuovamente
scurendolo. Lo stesso
artista afferma: “Voglio che il soggetto da me ritratto “esca”, venga fuori dal foglio,
allo stesso tempo, “colpisca”, impressioni, ed attragga a se l’osservatore”. La sensibilità
di Domenico Signorello, per il volume, per il risalto del soggetto nello
spazio del quadro, ereditata dalla frequentazione dei maestri reali - artisti
componenti la cosiddetta
“Scuola di Catania” - come Nunzio Sciavarrello
(1918), Francesco
Ranno (1907-1986), Carmelo Comes
(1905-1988), Pippo
Giuffrida (1912-1977) – e artisti ideali come l’amato Van
Gogh. La sua ricerca
disegnativa trova nella ripetizione il mezzo per avvicinarsi a un’ideale
”perfezione”. Nei suoi disegni e nei suoi quadri questa perfezione è perseguita con variazioni,
sperimentazioni e innovazioni, ma anche reinizi e trasformazioni dello stesso
e sullo stesso lavoro, ripreso nel tempo. Questa pratica operativa porta
l’artista a un personalissimo (forse inconscio) risultato – elevato -,
nonostante lo stesso consumo e disfacimento dei supporti utilizzati - con
impiego particolare di fogli di carte, di tele e supporti vari (come se egli
non desse importanza ai materiali in se, ma piuttosto a uno sfogo operato
come primaria urgenza provocata dall’incalzare gremito della vita), ed è così
che spesso i suoi lavori si presentano con un so ché di “vissuto”,
consumato, (con presenza di buchi, tagli… ect. provocati proprio perché in
quel momento: “nell’attimo
vivo” , l’arte, prende il sopravvento - “ci si dimentica di tutto” - e vince anche
sui materiali). L’artista parla
dell’arte come necessità e bisogno; infatti, quando gli si chiede
ironicamente se artisti si nasce o si diventa, egli risponde - con una
certezza dissacrante che toglierebbe il dubbio al più accanito dibattito - : “Artisti
si nasce, l’arte è qualcosa che hai dentro”. Egli parla
dell’arte come “una forza cui non ci
si può sottrarre”…: “Quando viene l’ispirazione, devo immediatamente
seguirla –afferrando l’attimo - utilizzando i mezzi che ho più a portata di
mano, imprimendo ciò che vedo su qualsiasi supporto (giornali, calendari,
spesso carte già usate per altri scopi, carte già scritte, quaderni dei miei
figli o trovati in giro… ect.); una volta ho fatto un autoritratto imbevendo
un fiammifero nella china (aggiungo
con strabiliante risultato: tanto che quando me lo ha detto non ci credevo
data la fluidità della linea!). Parlando
dell’arte come ”terapia”, lo Stesso artista conferma: “In molti momenti difficili della vita, l’arte può aiutare a superarli”. La costanza del
suo lavoro e la mole smisurata nel corso degli anni, unite alla
sperimentazione dei mezzi, hanno portato alla produzione, nei suoi
autoritratti di una multiforme e diversificata varietà di stili e di
soluzioni espressive. Negli autoritratti di Domenico Signorello sembra - pur
superando il limite del luogo in cui sono stati prodotti - trovare una
risposta alle esigenze espressive e comunicative del discorso pittorico
contemporaneo, divenendo “segno” dei nostri tempi. Sen & Sign |
Domenico Signorello
L’artista nel suo studio |
|
"Paesaggio della Germania" anni settanta. |
|
|
“Veduta dei tetti di Catania,” anni novanta |
|
|
L’artista all’opera - Agosto 2011 |
|
|
"Autoritratto". Agosto 2011 (particolare). |
|